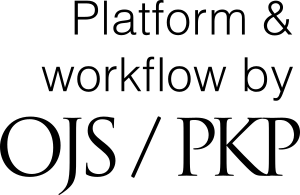Trump e la passione per i muri
di Irene Spigno
Già dalla campagna elettorale, il tema dell’immigrazione – vista come un qualcosa di estremamente pericoloso, altamente incontrollabile e assolutamente catastrofico per il popolo statunitense – ha svolto un ruolo centrale nella strategia politica di Donald Trump.
La conferma della politica della “tolleranza zero” nei confronti degli immigrati non si è fatta attendere: ad appena 7 giorni dal suo giuramento come 45esimo Presidente degli Stati Uniti d’America, Trump ha adottato le prime misure in materia di cd. “travel ban”[1], prevedendo specifiche restrizioni di accesso al territorio statunitense ai cittadini di diversi stati a maggioranza musulmana (tanto che si è cominciato a parlare di “muslim ban”).
È storia nota che i giudici dei gradi inferiori sono stati coloro che hanno bloccato l’esecutività dei “travel ban” per la loro presunta incostituzionalità, orientamento peraltro recentemente disatteso da una piuttosto polemica decisione emessa da una Corte suprema spaccata sul punto (la decisione è stata raggiunta da una – risicata – maggioranza di 5 giudici contro 4)[2]. Il Chief Justice Roberts ha motivato la decisione della maggioranza facendo leva prevalentemente su due argomenti: innanzitutto, il Presidente, con l’approvazione delle varie misure limitatrici dell’accesso di determinati cittadini agli Stati Uniti, avrebbe esercitato un potere nei limiti di quanto previsto dall’Immigration and Nationality Act (INA). Difatti, l’art. 1182 (f) dell’INA, che consentirebbe al Presidente di sospendere l’entrata degli stranieri nel caso in cui ritenga che il loro ingresso possa danneggiare gli interessi degli Stati Uniti, è stato interpretato con una profonda deferenza da parte della Corte, considerando legittime le motivazioni addotte dal Presidente a giustificazione della normativa impugnata, così respingendo tutti gli argomenti presentati dai ricorrenti. Inoltre, il “travel ban” non violerebbe nemmeno l’Establishment Clause del I Emendamento della Costituzione USA: difatti, si tratterebbe di misure che solo intendono perseguire un fine legittimo – e cioè quello di proibire l’entrata di stranieri che non possono essere adeguatamente “controllati” e così obbligare gli Stati a migliorare le loro pratiche – dato che non vi è nessun riferimento – esplicito almeno – alla religione.
La “tolleranza zero” di Trump non si è scagliata solamente contro gli immigrati di origine musulmana. Difatti, uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale è stata la protezione degli Stati Uniti contro quello che secondo il Presidente americano è lo Stato più pericoloso del mondo: il Messico[3].
Nonostante il Messico affronti un serio problema di sicurezza interna, dovuto prevalentemente alla presenza di gruppi narcotrafficanti che controllano diverse parti del territorio, è molto lontano dall’essere considerato il paese più pericoloso del mondo. Peraltro, intense sono le relazioni commerciali tra Stati Uniti e Messico (che non può essere assolutamente considerato come il vicino povero) e oltre 35 milioni di messicani risiedono – legalmente – negli Stati Uniti, rappresentando circa il 10% della popolazione.
A onor del vero, ogni anno milioni di persone cercano di attraversare illegalmente – rectius, senza i documenti per poterlo fare – la frontiera tra Stati Uniti e Messico: non si tratta di quegli “stupratori” e “assassini” messicani di cui parlava Trump durante la sua campagna elettorale, ma di milioni di persone che scappano dalla violenza e dai conflitti che sconvolgono la maggior parte dei paesi dell’America Latina (Honduras, El Salvador, Venezuela, per esempio).
La proposta dell’allora candidato presidente statunitense per risolvere il problema dell’immigrazione, e proteggere così il territorio e i cittadini americani, era quella di costruire un muro al confine tra Messico e Stati Uniti; muro che, secondo Trump dovrebbe essere pagato proprio dai messicani.
Una volta eletto, il presidente Trump non si è scordato delle sue promesse elettorali e fin da subito ha cominciato a fare pressioni sul Congresso affinché si inserisse nella legge finanziaria una partita specifica di circa 20 miliardi di dollari dedicata alla costruzione del muro, oltre che delle somme necessarie per mantenere la polizia di frontiera più la previsione di alcune misure normative per rendere più facili le espulsioni. Così, l’amministrazione Trump decide di revocare il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), un programma adottato dal ex presidente Obama e che avrebbe consentito ai dreamers – tutti quei giovani immigrati che erano entrati negli Stati Uniti illegalmente quando erano ancora minorenni – di realizzare il proprio sogno e quindi di evitare il rimpatrio ad un paese dal quale erano scappati o molto probabilmente nel quale non avevano nemmeno mai vissuto. La revoca del DACA consentirebbe l’espulsione immediata di centinaia di migliaia di persone, ormai perfettamente integrate nella società americana. Ma il tentativo di pressione di Trump non è andato a buon fine, a causa dell’opposizione nel Congresso tanto dei democratici quanto degli stessi repubblicani.
Fallito per il momento il tentativo di costruzione del muro tra Messico e Stati Uniti, il presidente Trump non si è dato per vinto e ha comunque fatto in modo che si costruissero altri muri.
Nel mese di aprile, Trump ha dichiarato l’intenzione di inviare fra le 2000 e le 4000 unità della National Guard of Unites States al confine per garantire la sicurezza degli Stati Uniti rispetto allo Stato più pericoloso del mondo e che dovrebbero rimanere in situ fino a quando la costruzione del muro non sarà avanzata. Un muro umano quindi.
Ma Trump ha costruito anche un altro muro, invisibile, ma impossibile da superare, che spezza le famiglie, che permette alle autorità di separare i migranti adulti che cercano di entrare – seppure illegalmente in quanto senza documenti – negli Stati Uniti dai loro figli minori.
Minori che vengono rinchiusi in centri di accoglienza (leggasi gabbie), affidati ad un istituto e privati dei più fondamentali diritti umani.
Minori che sono trattenuti negli Stati Uniti quando i loro genitori saranno molto probabilmente rimpatriati nel paese di origine e privati di qualunque possibilità di riunirsi con i loro figli, visto che la “tolleranza zero” ne impedisce il ritorno sul territorio statunitense per cercarli.
Perché in fondo la politica della “tolleranza zero” significa anche questo: confondere quella che è una crisi umanitaria con un pericolo per la sicurezza e così giustificare la disumanizzazione.
Peraltro, la “tolleranza zero” non è servita a ridurre il flusso migratorio. Anzi. Secondo i dati della Homeland Security, tra marzo 2017 e marzo 2018 il flusso migratorio dal Messico agli Stati Uniti è aumentato di oltre il 200%; tra febbraio e marzo del 2018 l’aumento è stato di quasi il 40% (la più alta registrata in un solo mese dal 2011). Questi dati si traducono in oltre 2300 bambini separati dai propri genitori e privati dei loro più elementari diritti umani.
Dove sta il diritto fondamentale alla famiglia? Che fine ha fatto l’interesse superiore del minore? E il diritto al giusto processo?
Gli effetti delle politiche migratorie del Presidente Trump hanno scosso l’intera comunità internazionale e il 20 giugno è stato firmato l’Ordine esecutivo n. 13841, intitolato “Affording Congress an Opportunity to Address Family Separation” che conclude – per il momento – la vicenda della separazione delle famiglie di migranti irregolari al confine tra Messico e Stati Uniti. Ora la palla passa al Congresso, ma la fine della tragedia umanitaria e della disperazione di milioni di persone sembra ancora lontana.
D’altronde, come già aveva detto l’ex Presidente messicano Porifirio Díaz: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.”
[1] Si tratta degli Ordini esecutivi n. 13769 e n. 13780, adottati rispettivamente il 27 gennaio 2017 e il 6 marzo 2017 e la Proclamazione presidenziale n. 9645 del 24 settembre dello stesso anno. L’Ordine n. 13769, intitolato “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States”, riduceva il numero di rifugiati da ammettere negli Stati Uniti nel 2017 a 50.000, sospendeva per 120 giorni il U.S. Refugee Admissions Program (il programma americano di ammissione dei rifugiati) e l’ingresso dei rifugiati siriani a tempo indefinito e vietava l’ingresso per 90 giorni, nel caso in cui non soddisfacessero i requisiti richiesti dalla normativa sull’immigrazione, ai cittadini provenienti da Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Tale Ordine rimase in vigore fino all’entrata in vigore dell’Ordine n. 13780 che eliminò l’Iraq dalla “black list”. La lista dei paesi i cui cittadini non erano più i benvenuti negli Stati Uniti è stata poi ampliata dalla Proclamazione presidenziale n. 9645, che comprendeva oltre agli Stati già compresi nei due precedenti Ordini esecutivi, anche il Ciad, la Corea del Nord e il Venezuela (mentre è stato rimosso il Sudan).
[2] Corte Suprema, Trump, President of the United States, et el. v. Hawaii et al. [585 U. S. ____ (2018)]. Il Chief Justice Roberts ha scritto l’opinione di maggioranza alla quale hanno votato a favore anche i giudici Kennedy, Thomas, Alito e Gorsuch (Thomas e Kennedy hanno scritto due concurring opinions), mentre Breyer e Sotomayor sono gli autori di due dissenting opinion, alle quali si sono uniti, rispettivamente, i giudici Kagan e Ginsburg. In particolare, di grande rilievo critico é la dissenting opinion della giudice Sotomayor, secondo la quale la decisione della Corte non farebbe altro che confermare il proprio precedente Korematsu v. U.S.[ 323 U.S. 214 (1944)] con il quale era stata confermata la costituzionalità dell’Ordine esecutivo n. 9066 che disponeva l’internamento in appositi campi dei giapponesi presenti nel territorio americano durante la seconda guerra mondiale indipendentemente della cittadinanza, affermando «The court redeploys the same dangerous logic underlying Korematsu and merely replaces one ‘gravely wrong’ decision with another.»
[3] Si veda infatti il tweet del Presidente Trump del 18 gennaio 2018 secondo cui “Mexico is now rated the number one most dangerous country in the world”, giustificando così le diverse restrizioni e limiti a cui sono sottoposti i funzionari governativi per recarsi in vacanza in Messico.