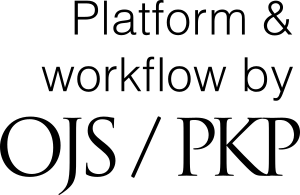La politica estera di Trump, un primo bilancio
di Mario Del Pero - 5 marzo 2018
Muri al confine con il Messico; azioni militari risolute contro il terrorismo di matrice islamica; guerre commerciali sulle rotte transatlantiche e transpacifiche; ripristino della relazione speciale con Israele; creazione di un nuovo asse con Mosca; sostegno alla Gran Bretagna e, nel continente, alle forze dichiaratamente ostili all’Unione Europea; rovesciamento delle aperture obamiane a Iran e Cuba. Questo e molto altro aveva promesso Donald Trump prima di essere eletto Presidente nel novembre del 2016. Racchiusa nello slogan “America First”, la retorica trumpiana offriva un messaggio di politica estera radicale e fortemente eccentrico rispetto ai canoni consolidati del moderno internazionalismo statunitense, liberal o conservatore esso fosse.
Che primo bilancio si può tracciare a 13 mesi dall’insediamento di Trump alla Casa Bianca? Quali sono le discontinuità più marcate, e le continuità meno attese, tra questa prima fase e gli otto anni di Obama? Che costrizioni, strutturali e contingenti, hanno operato nel limitare la flessibilità dell’azione internazionale dell’amministrazione repubblicana?
Il bilancio – ovviamente parziale – è quello di un Presidente che a dispetto delle previsioni non ha dismesso i toni estremi (e talora quasi caricaturali) del periodo elettorale, ma che fatica poi a realizzare politiche rivelatesi spesso velleitarie e irrealistiche. Trump pare incapace di farsi più sobrio e presidenziale, e la rappresentazione della sua politica estera e della strategia che la dovrebbe informare continua a caratterizzarsi per la sua radicalità. Lo si è visto bene nei tanti interventi pubblici del Presidente e, anche, nella prima National Security Strategy (NSS) di questa amministrazione, resa pubblica nel dicembre scorso[1]. Un documento, questo, dove dominante e finanche ostentata è una rappresentazione delle relazioni internazionali come un’arena anarchica e brutale, in cui ogni attore cerca di massimizzare i propri interessi e dove la moralità della politica estera di qualsiasi soggetto – Stati Uniti inclusi – è definita dalla sua capacità di tutelare e promuovere l’interesse nazionale (“Anteporre l’America – Putting America First”, si afferma, “è il dovere del nostro governo e il fondamento della leadership statunitense nel mondo”).
Per quanto declinata in modo sovraccarico e binario, questa retorica simil-realista (di principled realism, secondo la NSS di Trump) rivela tuttavia una paradossale somiglianza con quella utilizzata da Obama. Il quale parlò anch’egli un linguaggio pragmatico e realista, centrato sulla sottolineatura dei nuovi limiti con cui gli Stati Uniti si dovevano confrontare, con la conseguente necessità di definire una gerarchia di priorità strategiche per Washington e con l’invito a fare un uso parsimonioso e selettivo di quell’hard power militare che rimane, a oggi, l’elemento primario della superiorità di potenza di cui ancora godono gli Usa[2].
Con un evidente, marcato scarto di sofisticatezza ed eleganza, sia Obama sia Trump hanno insomma cercato di offrire una lettura realista delle relazioni internazionali. Una lettura, questa, capace di recepire le sollecitazioni provenienti da un’opinione pubblica interna prostrata dalle fallimentari guerre statunitensi del XXI secolo, oltre che dagli effetti della crisi del 2008, e refrattaria quindi a sostenere onerose politiche interventiste quali quelle di George Bush Jr. o di Bill Clinton.
Direttamente legato a questo, vi è un secondo possibile elemento di continuità tra le due ultime amministrazioni: l’adozione di un approccio particolarista e selettivo, capace di discriminare tra i teatri (e i problemi) strategicamente vitali e quelli invece secondari, concentrando sui primi energie e risorse fattesi vieppiù limitate. Agiscono, su questo, sia l’onda lunga dei disastri provocati dall’hybris globalista dei neoconservatori e dei liberal interventisti, sia la consapevolezza che la costruzione del consenso interno passa anche attraverso la capacità di soddisfare un’opinione pubblica che chiede un parziale disimpegno dalla scena mondiale. E pesa, altresì, l’ovvia consapevolezza che anche un attore globale come gli Stati Uniti – anche l’egemone dell’ordine corrente – debba definire una scala d’interessi e priorità. Alla testa dei quali, per Trump come per Obama, non può che essere la relazione profonda, complessa e fondamentale con la Cina. Una relazione, questa, caratterizzata da forme contraddittorie e ineludibili d’interdipendenza - da spinte oggettive alla cooperazione e tentazioni competitive - e simboleggiata da uno squilibrio nella bilancia commerciale bilaterale che dopo la parziale contrazione post-2008 è tornato a crescere senza tregua (con un deficit statunitense che nel 2017 ha raggiunto la cifra record di 375 miliardi di dollari)[3].
Laddove, però, l’amministrazione Obama aveva in più riprese enfatizzato la naturale convergenza d’interessi con Pechino, e la necessità d’integrare la Cina nell’ordine liberale a leadership statunitense, con Trump l’accento è stato (e continua a essere) posto sulla dimensione intrinsecamente antagonistica dei rapporti sino-americani. Di nuovo, la retorica è anche funzione di dinamiche politiche interne e riflette la forza, entro il conservatorismo statunitense, di un’ostilità alla Cina che talora tende a degenerare in vera e propria sinofobia. La NSS di Trump presenta quindi esplicitamente la Cina come un rivale strategico: una potenza “revisionista”, si afferma, che al pari della Russia ambirebbe a competere con gli Usa, a creare un “mondo antitetico ai valori e agli interessi statunitensi” e a “sostituire” gli Stati Uniti come leader della “regione indo-pacifica”[4].
A questa prima, significativa differenza con gli anni di Obama – l’enfasi sulla Cina come avversario naturale e non partner degli Usa - se ne è aggiunta una seconda relativa al teatro mediorientale, dove la nuova amministrazione repubblicana ha finora cercato di rovesciare l’approccio di quella precedente. Con Trump alla Casa Bianca si è quindi assistito al tentativo di ripristinare una politica di alleanze centrate sui partner storici di Washington nella regione: Israele, Egitto, Arabia Saudita. Le pesanti critiche all’accordo sul nucleare iraniano e la denuncia dell’Iran (presentato nella NSS come l’altro paria, assieme alla Corea del Nord, intento a “destabilizzare” l’ordine mondiale, “minacciare l’America e i suoi alleati” e “brutalizzare” la sua stessa popolazione) rispondono anche alla volontà di mettere in discussione l’obiettivo obamiano di coinvolgere Teheran nel complesso gioco mediorientale, oltre che a considerazioni di ordine politico e di costruzione del consenso interno[5].
Infine, due altri ambiti di accentuata discontinuità (e, ancora una volta, di stretta interdipendenza tra dinamiche interne e politica estera) sono rappresentati dall’ambiente e dalle spese militari. Gli accordi di Parigi del dicembre 2015 per il contenimento del cambiamento climatico furono resi possibili dalla svolta impressa alle politiche ambientali da Obama; analogamente, lo smantellamento per via amministrativa della regolamentazione introdotta dal suo predecessore è stata propedeutica alla decisione di Trump di uscire dalla cornice definita a Parigi, considerata inutile e nociva rispetto all’obiettivo, delineato nella NSS, di fare degli Usa un paese nuovamente “dominante nel settore dell’energia” (an energy-dominant nation). Un dominio da preservare ed estendere anche in un ambito, quello militare, dove il gap di potenza tra gli Stati Uniti e il resto del mondo rimane assai marcato. Per poter godere di un overmatch militare o quella che la NSS definisce una full spectrum dominance, l’amministrazione Trump si propone di rovesciare il significativo calo nel bilancio del dipartimento della Difesa degli anni di Obama, quando le spese militari passarono dal 4.7 al 3.3% del PIL[6]. Per quanto le cifre siano variate più volte, si prevede che con Trump gli investimenti in difesa e sicurezza nazionale tornino quindi a crescere in modo considerevole[7].
Le scelte di politica estera di una grande potenza, anche quelle dell’unica grande superpotenza globale, sono però soggette a costrizioni e vincoli, interni e internazionali. Non fa eccezione la politica estera trumpiana, che si è da subito dovuta confrontare con ostacoli che hanno impedito la realizzazione di alcuni suoi obiettivi o che hanno di molto attenuato la rottura promessa. Se la retorica è stata, e rimane, estrema, forse anche più delle previsioni e delle aspettative, non altrettanto si può dire delle scelte e delle politiche. Anzi, la discrasia tra le due è stata spesso visibile se non eclatante, laddove alcune delle iniziative all’apparenza più radicali – come il ritiro dall’accordo commerciale transpacifico (Trans-Pacific Partnership, TPP) – certificavano in realtà scelte già compiute e si caratterizzavano per la loro valenza precipuamente simbolica. Molti esempi possono essere offerti, ma due casi paradigmatici di ostacoli strutturali ovvero d’impedimenti politici aiutano a comprendere limiti e possibilità della realizzazione dei progetti trumpiani. Il primo è relativo al dossier più problematico e complesso con cui l’amministrazione repubblicana si è dovuta confrontare, quello costituito dalla Corea del Nord e dal suo programma nucleare. Il secondo è invece rappresentato da una delle promesse elettorali centrali di Trump: quella di costruire un asse privilegiato con la Russia di Vladimir Putin, da spendersi soprattutto in Siria. Nel caso della Corea del Nord, le roboanti minacce di Trump si sono rapidamente infrante sull’intrattabilità di una crisi che non può conoscere soluzione militare e che rischia di scatenare una corsa al riarmo regionale dai pericoli immensi. Per quanto riguarda la Russia, invece, il promesso rapprochement con Mosca si è subito dovuto confrontare con l’ostilità di una parte non marginale del partito repubblicano (e dei suoi rappresentanti al Congresso) oltre che con i riverberi dello scandalo, e delle successive inchieste, sulle ingerenze russe nella campagna elettorale del 2016. Uno degli obiettivi della nuova politica statunitense verso la Russia – la graduale rimozione delle sanzioni imposte dopo la crisi ucraina e l’annessione della Crimea – non solo non è stato realizzato, ma il Congresso in uno dei rari momenti bipartisan di questa legislatura e contro le richieste e pressioni del Presidente ha addirittura approvato un’estensione e intensificazione di tali sanzioni. Nuove sanzioni che Trump ha dovuto firmare, visto che la maggioranza era a prova di veto, anche se in seguito ha cercato di evitarne l’applicazione.
I due casi in questione ci rivelano quindi quanto complessa posse essere la conduzione di una politica estera coerente con le promesse della campagna elettorale e con la sua retorica. A maggior ragione se, come nel caso di Trump, questa retorica è tanto ambiziosa quanto, spesso, approssimativa e grossolana.
[1] Dalla fine degli anni Ottanta, con cadenza prima annuale e poi più o meno quadriennale, le amministrazioni in carica producono e rendono pubblica la loro “Strategia di Sicurezza Nazionale”. Si tratta di documenti dalla valenza tanto analitica quanto prescrittiva, funzionali alla costruzione del consenso interno e internazionale attorno alle scelte fondamentali di politica estera. La prima “National Security Strategy” di Trump è accessibile all’indirizzo https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
[2] Tra i tanti esempi possibili del “realismo obamiano” e delle sue matrici cristiane, si veda ad esempio il suo discorso in occasione del conferimento del premio Nobel per la Pace (accessibile all’indirizzo https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html).
[3] Https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html.
[4] “Per decenni”, afferma il documento, “la politica degli Stati Uniti si è fondata sul convincimento che sostenere l’ascesa della Cina e la sua integrazione nell’ordine internazionale postbellico l’avrebbe liberalizzata. In contrasto con le nostre speranze, la Cina ha visto accresciuto il proprio potere a discapito della sovranità altrui”.
[5] Secondo tutti i sondaggi di cui disponiamo, una larga maggioranza dei cittadini statunitensi continua ad avere un’opinione estremamente negativa dell’Iran (si veda ad esempio la rilevazione Gallup all’indirizzo http://news.gallup.com/poll/116236/iran.aspx).
[6]Https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=US&order=wbapi_data_value_2012+wbap.
[7] Susanna V. Blume, The True Cost of Trump’s National Defense Strategy, “Foreign Affairs”, 19 Febbraio 2018 (https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2018-02-19/true-cost-trumps-national-defense-strategy?cid=int-fls&pgtype=hpg).