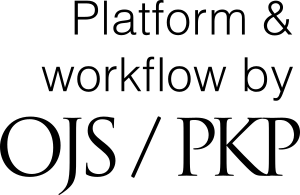Archivio - Don’t ask why: l’immigrazione nell’era (caotica) di Trump
Archivio - Don’t ask why: l’immigrazione nell’era (caotica) di Trump[1]
di Graziella Romeo
Quando il Presidente Trump ha emanato l’Executive Order n. 13769 sulla limitazione dei flussi migratori qualche commentatore ha immaginato si trattasse di una scelta poco meditata, da inquadrarsi nel caos politico dei primi giorni della nuova presidenza (v. Wallace-Well). Invece, l’Order che impedisce l’ingresso ai cittadini di sette paesi islamici per 90 giorni e blocca l’accoglienza dei rifugiati siriani a tempo indeterminato (mentre di 120 giorni è limite per i rifugiati in genere) esprime chiaramente la linea di fondo della politica immigratoria di Trump. Quest’ultima è peraltro confermata dall’emanazione, il 6 marzo scorso, di un nuovo Executive Order che prolunga la durata del primo immigration ban ed espunge l’Iraq dalla lista dei paesi i cui cittadini sono indesiderati, in ragione dell’asserito recente impegno iracheno nel contrastare l’immigrazione clandestina in uscita.
Alla luce dei due orders si sarebbe tentati di sintetizzare la politica immigratoria di Trump nella scelta di operare una selezione all’ingresso non solo del tipo di immigrazione (economica, non dettata dalla disperazione per le condizioni socio-politiche del paese di provenienza), ma anche, e assai meno ragionevolmente, della nazionalità o dell’area geografica di origine, soprattutto in ragione dell’ossessione per la sicurezza nazionale. A ben vedere, questa conclusione è semplicistica nel senso che la decisione presidenziale appare irragionevole perché non inquadrabile in un’autentica strategia di gestione dell’immigrazione.
Le motivazioni del Presidente neoeletto, in particolare la retorica securitaria e la paura del terrorismo jihadista, sono piuttosto deboli se messe alla prova di almeno due argomenti. In primo luogo, nella lista dei sei paesi (Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen) non rientra l’Arabia Saudita, che pure è lo Stato di provenienza della metà dei terroristi dell’11 settembre; di contro, l’elenco comprende luoghi dai quali non sono mai provenuti individui che abbiano commesso attentati sul territorio americano. In secondo luogo, gli ultimi episodi di terrorismo paiono suggerire che concentrarsi prioritariamente sulla derivazione esterna della minaccia terroristica è solo parzialmente utile, posta la frequenza con cui sono stati rilevati azioni terroristiche ovvero atti preparatori di attentati jihadisti da parte di individui che possedevano la cittadinanza americana, formalmente integrati nella comunità politica. È ormai chiaro, insomma, che il fenomeno terroristico è assai più complesso di come lo immaginava Bush durante il suo primo mandato (Hastings Dunn, Bush, 11 September and the Conflicting Strategies of the ‘War on Terrorism’, in 16 Irish Stud. Int’l Affairs, 2005, p. 15 ss.) e richiede una strategia che agisca su più fronti, non surrogabile da una politica immigratoria selettivamente restrittiva.
Se la retorica nazionalista e securitaria, per un verso, non trova appiglio nei dati di realtà, per l’altro è tradotta in una scelta politica che riflette un modo di interpretare la minaccia terroristica ampiamente smentito dalle indagini più accorte.
I due orders tradiscono insomma la vera natura della decisione della nuova Presidenza, che mira essenzialmente alla riduzione progressiva dei flussi migratori in termini assoluti, specialmente di quelli più onerosi dal punto di vista dell’accoglienza e cioè dei rifugiati. Non vi è infatti prova di una connessione diretta tra il blocco dell’immigrazione e la riduzione della minaccia alla sicurezza nazionale.
Il divieto colpisce anche coloro che, possedendo le caratteristiche descritte nell’Executive Order n. 13769, si trovino negli Stati Uniti con un visto temporaneo per ragioni di studio o di lavoro (secondo l’Institute of International Education, 17354 studenti provenienti dai sette paesi musulmani citati sono attualmente iscritti nelle Università americane: v. Singhvi, Parlapiano). A queste persone sarebbe impedito con effetto immediato l’ingresso negli Stati Uniti e, dunque, di rientrarvi qualora lasciassero il territorio americano durante la vigenza del provvedimento presidenziale.
L’applicazione del primo Executive Order è stata sospesa, su tutto il territorio nazionale, da una serie di pronunce di corti federali (da Seattle a New York), intervenute in alcuni casi su impulso di Stati riluttanti ad applicare il provvedimento presidenziale (così per Washington e per Minnesota) ovvero di privati. Le decisioni hanno fatto salva la condizione di chi fosse già in possesso di un visto temporaneo e di coloro che si trovassero in transito negli Stati Uniti al momento dell’entrata in vigore del provvedimento. In questo modo, i giudici hanno posto fine alla detenzione di decine di immigrati negli aeroporti di New York e Los Angeles (v. Robbins, Dickerson).
Si tratta, in tutti i casi, di provvedimenti cautelari succintamente motivati e, in dettaglio, di temporary restraining orders, ovvero di ordinanze con cui le corti preservano lo status quo in attesa di decidere su un eventuale preliminary injuction. In quasi tutti i casi, i giudici federali si sono limitati a dichiarare l’esistenza del fumus boni iuris.
La District Court di New York, invece, è ricorsa anche alle clausole del Due Process e dell’Equal Protection per sostenere la plausibilità, nel merito, del claim avanzato dalla parte attrice.
Judge Robart, della District Court di Seattle, ha però arricchito la motivazione, giustificando la decisione con un richiamo al principio di separazione dei poteri e al rispetto della Costituzione. Il giudice federale ha precisato che non spetta al potere giudiziario dettare policy, né tantomeno giudicarne la bontà o l’opportunità. Tuttavia, il principio di costituzionalità dell’ordinamento consente al giudice di bloccare quelle iniziative degli altri due poteri che si pongano in contrasto con la Costituzione, quand’anche tale decisione produca un considerable impact sul governo federale.
Il neo eletto Trump ha criticato l’intervento degli organi giudiziari, definendo in particolare il giudice Robart, il primo a sospendere l’applicazione del provvedimento in via cautelare, «a so-called judge», autore di una «ridiculous opinion». L’esternazione ha suscitato un’ondata di critiche; la più interessante è contenuta nell’editoriale con cui Eric Posner esorta Neil Gorsuch – designato successore di Scalia alla Corte Suprema a esprimere pubblicamente la sua distanza dalle affermazioni presidenziali – lesive dell’autonomia e del prestigio della magistratura (Posner, Gorsuch Must Condemn Trump’s Attack on a Judge, in The New York Times, 4 February 2017, pubblicato anche qui). Gorsuch ha raccolto l’invito e condannato le dichiarazioni di Trump, nel tentativo di marcare una certa autonomia ideologica e, al contempo, evidenziando la natura intemperante del neoeletto presidente.
Qualche giorno prima gli imprenditori della Silicon Valley e i Deans delle Università americane avevano espresso disappunto, in qualche caso sconcerto, per un provvedimento che mortifica l’investimento nel talento e nella ricerca, a prescindere dalla nazionalità di provenienza, di lavoratori e studenti musulmani giornalmente impegnati nelle aziende dell’high tech o in prestigiosi centri universitari e di ricerca americani.
Lo sconcerto non è però soltanto di Posner, della Silicon Valley, delle Università. Questo dissenso è prevedibile e fisiologico, una modesta cartina di tornasole della realtà americana. Ciò che contribuisce a rendere la decisione presidenziale una scelta eccentrica, episodica e incoerente è la reazione di una porzione consistente della sua stessa base elettorale. Preoccupazione e disorientamento sono stati espressi anche dagli amministratori cittadini della cosiddetta Rust Belt, ovvero di quella fascia del Midwest che ha ampiamente contribuito al successo di Trump (v. Connors e l’analisi svolta in queste sede da Mostacci). L’immigrazione è percepita come una risorsa per l’economia del Paese e nello specifico di quella porzione del territorio americano.
I provvedimenti presidenziali, in altri termini, non possono essere inquadrati nell’ambito di una strategia politica che mira a favorire un certo tipo di immigrazione o, per meglio dire, a selezionare all’ingresso sulla base delle necessità dell’economia americana (secondo un approccio comune in alcuni Paesi dell’Europa, tra cui la Francia e la Germania, negli anni sessanta e settanta: v. Zincone, Da sudditi a cittadini: le vie dello Stato e le vie della società civile, Bologna, il Mulino, 1992, p. 237). Non si tratta neppure di scelte che si inseriscono in un disegno razionale di controllo dei flussi di profughi e rifugiati, posto che il blocco temporaneo rischia solo di rendere il problema più pressante tra qualche mese e la cooperazione con il Canada, sul riparto dell’onere di accoglienza, più complessa.
I due orders esprimono assai più banalmente la chiusura di una comunità politica secondo una logica di amico/nemico antistorica e non solo anacronistica. In un’epoca in cui l’immigrazione rappresenta l’acme di una serie di tensioni globali, legate alla dialettica tra il nord e il sud del mondo ma anche al complessivo atteggiarsi di equilibri geopolitici in fase di rapido e imprevedibile mutamento, la decisione di innalzare muri sul confine messicano, chiudere temporaneamente l’ingresso da una selezione di paesi e fermare l’arrivo dei rifugiati, ignora che la gestione dei flussi migratori è razionale solo se frutto di programmazione strategica.
Tale attitudine progettuale, poi, può declinarsi nella direzione della costruzione di percorsi di accoglienza, nella prospettiva dell’integrazione politica piena e cioè dell’acquisto della cittadinanza. Anzi, le spinte nazionalistiche di una certa parte dell’ala conservatrice potrebbero essere più utilmente indirizzate verso la ridefinizione dell’istituto della cittadinanza, come è avvenuto sul finire del mandato presidenziale di Bush. Infatti, nel 2007 il Congresso discusse addirittura la riforma dello ius soli, che negli Stati Uniti ha la dignità del principio costituzionale, contenuto nel XIV Emendamento. Per la verità Lincoln volle la birthright citizenship a sugellare l’eguaglianza di tutti coloro che erano nati sul territorio americano, nell’ottica di privare di base giuridica la discriminazione razziale. L’attualità di quel principi può oggi essere ridiscussa a parere di coloro che vi intravedono un incentivo all’immigrazione clandestina, posto che la nascita di un figlio sul territorio americano determina l’acquisto immediato della cittadinanza per quest’ultimo e un titolo di permanenza per la madre (v. Diaz Greene, Birthright Citizenship: Should the Right Continue?, in 9 J.L. & Fam. Stud., 2007, p. 159 ss.). Ma anche a prescindere da un mutamento così radicale, una possibilità perseguibile da un Presidente conservatore è quella di ridisegnare i modi di acquisto della cittadinanza per incontrare le esigenze dei tempi e nell’ottica di lungo periodo di istituire percorsi di integrazione, magari meno immediati e fondati sul progressivo radicamento del non-cittadino nella comunità politica di accoglienza.
In alternativa, una strategia di gestione dell’immigrazione di massa può sfociare nell’amministrazione dei flussi in entrata con una politica sul diritto all’asilo o al rifugio improntata alla valutazione individuale delle circostanze che legittimano la permanenza sul territorio dello Stato. Invero, una politica di questo genere è stata abbandonata dagli Stati Uniti già a partire dalla seconda metà degli anni novanta e cioè da quando le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale hanno determinato l’adozione di leggi draconiane che smentivano le promesse dal Refugee Act del 1980 (v. Churgin, p. 261 ss.). La cooperazione con il Canada, rafforzata a partire dagli attentati dell’11 settembre, dovrebbe però essere un aiuto sufficientemente consistente nel riparto dell’esame delle domande di rifugio e protezione internazionale e, conseguentemente, dell’onere di accoglienza.
Tutto ciò sembra, nell’impostazione della strategia di Trump e della sua amministrazione, secondario rispetto all’esigenza di difendere i confini del territorio nazionale. Quella del Presidente neoeletto però non è soltanto un’opzione politica che riflette una lettura della realtà incoerente rispetto al tempo in cui si colloca; si tratta di una decisione che offre una soluzione non rispondente alle esigenze dei tempi e fatalmente destinata ad essere inefficace e inconcludente.
[1] Il contributo è apparso anche sul blog della Società Italiana di Diritto Internazionale.