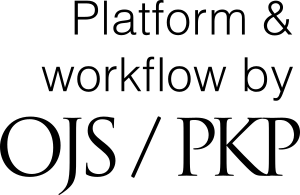TRUMP E LA FRATTURA EPISTEMICA DELLO STATO Dalla perturbazione fisiologica dell’interesse presidenziale alla deformazione della funzione cognitiva dell’intelligence: come l’ingresso della volontà nello spazio dell’articolo zero spinge il sistema verso la soglia dell’instabilità e del rischio entropico
di Ciro Sbailò
La narrazione mitica come dispositivo decisionale
Negli ultimi mesi del 2025 Donald Trump ha trasformato la comunità d’intelligence americana in un palcoscenico in cui politica, sicurezza e narrazione si intrecciano. L’episodio più emblematico è stato l’ordine di desecretare tutti i file su Amelia Earhart, la pioniera dell’aviazione scomparsa nel 1937. Non è stato un gesto marginale: quella che appare come una drawing-room quip — una leggerezza presidenziale — rivela invece il metodo con cui Trump struttura la realtà politica, includendo elementi simbolici nella catena decisionale.
La stessa logica si ritrova nell’Operazione Midnight Hammer, il raid statunitense del giugno 2025 contro le infrastrutture nucleari iraniane. Mentre fonti ufficiali americane parlano di “danni severi”, valutazioni indipendenti indicano che solo una parte delle installazioni è stata effettivamente compromessa e che il programma di Teheran ha subìto un rallentamento limitato. È in questo scarto fra narrazione presidenziale e analisi tecnica che si vede il punto di frizione: la comunicazione politica prevale sull’interpretazione prudenziale delle informazioni.
Il nodo diventa evidente nel rapporto fra Casa Bianca e comunità d’intelligence. Il Presidente tende a integrare i dati non come limite, ma come materiale plastico da piegare alla coerenza narrativa della decisione. La dialettica tradizionale — il mutual adjustment fra analisi delle agenzie e scelta del decisore — si assottiglia. Ed è in questo contesto che va letta la riorganizzazione dell’ODNI: riduzione di strutture, riallineamento di funzioni, chiusura di centri ritenuti politicamente sensibili.
Non sono semplici interventi amministrativi, ma un cambio di funzione: l’intelligence come infrastruttura narrativa dell’Esecutivo.
Gli effetti si vedono subito all’esterno. Regno Unito e Colombia rallentano gli scambi più sensibili, temendo che un ciclo decisionale instabile trasformi il materiale condiviso in strumento politico. A questo si aggiunge la designazione dei cartelli della droga come organizzazioni terroristiche: un salto giuridico che consente operazioni extraterritoriali senza autorizzazione del Congresso dilata impropriamente la categoria del terrorismo e apre a un uso della forza non soggetto ai vincoli tradizionali del diritto interno e internazionale.
Il rischio è duplice. Sul piano istituzionale, si cancella la distinzione fra minaccia criminale e minaccia politico-militare, complicando la cooperazione con Stati come Messico e Colombia e creando un precedente che amplia arbitrariamente l’ambito del controterrorismo. Sul piano operativo, si altera il comportamento dei cartelli stessi: organizzazioni orientate al profitto, non alla competizione politica, possono reagire in modo imprevedibile e più aggressivo se si percepiscono trattate come attori militari, con un potenziale aumento di violenza, frammentazione interna e alleanze opportunistiche con attori statali ostili agli Stati Uniti.
Le nuove operazioni clandestine della CIA in America Latina accentuano questa zona grigia fra narcotraffico e azione strategica, con ricadute sulla sovranità dei partner, sulla gestione congiunta dell’intelligence e sulla stabilità regionale.
Per gli alleati, il segnale è chiaro: la funzione epistemica dell’intelligence americana – stabilizzare, filtrare, prevedere – è stata assorbita dentro la logica della decisione politica. Non è in discussione l’alleanza, ma la fiducia cognitiva che la sosteneva.
Il limite epistemico della Presidenza
La frizione tra Casa Bianca e apparati informativi non è nuova nella storia americana. Dalla crisi dei missili a Cuba ai dossier sul Vietnam, dalle valutazioni sulla Prima Guerra del Golfo ai warning su Russia e Siria, l’intelligence ha sempre rappresentato una superficie ruvida che obbligava il Presidente a confrontarsi con fatti e incertezze non manipolabili. Non era un contrappeso politico: era un limite epistemico.
Il tratto distintivo del trumpismo è la rottura di questa dinamica. Trump non respinge singole analisi: respinge la funzione stessa dell’intelligence come sorgente di complessità e verità operativa.
L’intelligence come tutor cognitivo del potere
Negli Stati Uniti l’intelligence è il dispositivo attraverso cui opera ciò che chiamiamo “Articolo Zero”: il presupposto secondo cui la sicurezza dell’America è la condizione di esistenza della democrazia. È un principio che assicura la continuità costituzionale, ma contiene un’eccedenza di potenza: può giustificare deformazioni del diritto in nome della sopravvivenza, spingendo la volontà politica oltre i limiti posti a contenerla. Da qui la tendenza dell’apparato a difendere il proprio ruolo di presidio cognitivo del sistema.
Il riferimento allo “zero” viene dalla matematica contemporanea: insieme vuoto, elemento neutro, punto d’origine. Negli assiomi di Peano zero è un numero, ma occupa la posizione iniziale della sequenza aritmetica, bensì fonda la struttura che li organizza. Questa dinamica offre un’analogia utile per l’ordine politico. Un sistema costituzionale complesso — e quello americano, considerato nella sua modellizzabilità analitica, rientra in questa categoria — richiede un principio iniziale che precede le norme che da esso discendono. In questo quadro la lezione di Gödel è istruttiva, solo in senso analogico e senza alcuna trasposizione matematica al diritto. Il primo teorema mostra che un sistema formale coerente ed effettivamente descrivibile, quando raggiunge un certo livello di espressività, non può esaurire tutte le verità che contiene. Questa struttura concettuale offre un modello per comprendere i sistemi politici complessi: ogni ordine stabile poggia su un nucleo fondativo che non deriva dalle norme, ma ne rende possibile la coerenza complessiva.
A questo punto si potrebbe legittimamente osservare che il concetto riecheggia la Grundnorm kelseniana. L’assonanza è inevitabile. Ma non è questo il terreno su cui ci stiamo muovendo. Qui non interessa la fondazione ontologica dell’ordinamento, bensì la logica operativa che consente al sistema politico di distinguere ciò che desidera da ciò che è costretto a vedere (una discussione completa di questo nodo appartiene a un’altra sede; qui il riferimento serve soltanto a chiarire il funzionamento del dispositivo.)
In questo senso l’Articolo Zero assicura la coerenza dell’intero ordine costituzionale e definisce il quadro entro cui decisione, verità e strategia possono articolarsi. Ogni democrazia richiede un soggetto politico capace di sostenerla; ogni sistema libero presuppone un livello minimo di sicurezza che non è soltanto un bene pubblico, ma la condizione stessa di esistenza dello spazio pubblico definito a Philadelphia nel 1787 e consolidato dopo la Guerra Civile. Con l’emergere delle minacce ibride, questo presupposto ha progressivamente superato la dimensione interna, trasformandosi nel criterio che orienta anche la proiezione geopolitica degli Stati Uniti.
L’Articolo Zero è così il punto di contatto tra verità e potere, decisione e sopravvivenza, Costituzione e strategia. Ed è qui che l’approccio di Trump diventa rivelatore. Interferire con la funzione epistemica dell’intelligence significa alterare il meccanismo con cui l’Articolo Zero opera: la capacità del sistema di distinguere ciò che desidera da ciò che è costretto a vedere. In termini logici, sposta il confine tra presupposto e deduzione: la volontà presidenziale entra nel luogo che dovrebbe restare indipendente dalla volontà.
Negli Stati Uniti la Presidenza concentra narrazione, comando e decisione; questa configurazione la espone strutturalmente al rischio di autoreferenzialità. Il Presidente, per la natura stessa della funzione, tende a trasformare la propria percezione in criterio operativo. L’intelligence nasce precisamente per evitare questo collasso: agisce come tutor cognitivo della Presidenza, un meccanismo che introduce un livello esterno di verifica, contrasto e controllo della realtà. Non limita il potere esecutivo: ne garantisce la lucidità.
Il ruolo dell’intelligence non consiste nel proporre una verità alternativa, ma nel produrre un flusso di informazione che impedisce alla decisione politica di ripiegarsi su sé stessa. È un controcampo costante: osserva ciò che il potere non vede, misura ciò che la Presidenza tende a proiettare, segnala ciò che la volontà politica tende a ignorare. In questo senso l’intelligence è l’unico dispositivo istituzionale capace di sottrarre il Presidente alla tentazione, sempre presente, di auto-legittimarsi attraverso la propria narrazione.
La storia costituzionale americana mostra che questo equilibrio è delicato. Da Truman a oggi ogni amministrazione ha dovuto misurarsi con la pressione a piegare l’intelligence alla propria agenda; ma le dinamiche del 2025 riportano la questione alla sua forma elementare: la distinzione fra ciò che è osservato e ciò che il potere preferirebbe ritenere vero. Qui si vede la funzione profonda dell’intelligence come garante dell’Articolo Zero. La sopravvivenza nazionale è il principio implicito dell’ordine costituzionale, ma può essere amministrata dal Presidente solo attraverso un dispositivo cognitivo che ne delimita l’autoreferenzialità.
L’Articolo Zero non attribuisce al Presidente la facoltà di definire la realtà: gli affida, invece, la responsabilità di agire dentro una struttura che lo obbliga a confrontarsi con essa. L’intelligence rende possibile questa operazione: è la sua guida epistemica, la sua vigilanza contro il proprio stesso potere. Senza questo tutoraggio, la funzione presidenziale rischierebbe di trasformarsi in una forma di auto-legittimazione continua; con esso, rimane dentro l’orizzonte costituzionale che radica decisione, verità e strategia in un terreno comune.
La logica dell’intelligence americana affonda nella cultura costituzionale originaria. Quando Madison, nel Federalist n. 51, scrive che “il potere deve controllare il potere”, definisce il principio che impedisce al potere esecutivo di diventare divino: una Repubblica sopravvive solo se dispone di un meccanismo che la osservi dall’interno. È un’esigenza strutturale ed epistemica, non meramente legalistica: la conoscenza come forma di auto-limitazione, che impedisce al potere di divenire autoreferenziale e distruttivo. L’intelligence, un secolo e mezzo dopo, istituzionalizza questa esigenza, impedendo al Presidente — che concentra comando, velocità e segretezza — di trasformarsi in decisore assoluto.
Architetture comparate della verità politica
Il confronto con il Regno Unito chiarisce la specificità americana. In entrambi i sistemi l’eccezione affiora dal collasso della normalità; ma a Westminster viene riassorbita ex post: l’Indemnity Act sana retroattivamente lo strappo, preservando la sovranità parlamentare. Negli Stati Uniti, invece, l’eccezione è pre-autorizzata: il Congresso delega al Presidente poteri latenti prima che l’evento accada. Da qui il problema centrale: un Presidente che, se non controbilanciato, tende a occupare lo spazio del decisore totale. L’auto-limitazione non può venire dal diritto positivo, troppo lento: richiede un dispositivo cognitivo che riduca l’opacità dell’esecutivo.
Su questo sfondo si colloca il National Security Act del 1947: non una riforma amministrativa, ma l’organizzazione della funzione informativa come parte integrante dell’esercizio dei poteri presidenziali. CIA, NSC e Dipartimento della Difesa diventano gli strumenti attraverso cui la Presidenza deve vedere per poter decidere. L’Articolo II — riconoscerà la Corte Suprema in Department of the Navy v. Egan (1988) — è la fonte implicita del potere di raccogliere, classificare e proteggere informazioni.
Con la Guerra Fredda questa architettura si amplifica. La covert action diventa una forma di governo; il segreto, una modalità del diritto; l’oversight degli anni Settanta non riduce il sistema, ma ne istituzionalizza il metabolismo. L’intelligence assume così il profilo di un organo costituzionale implicito: custode della continuità repubblicana attraverso la gestione cognitiva della crisi.
La conclusione è imposta dalla simmetria del sistema: se l’intelligence regola l’espansione fisiologica del potere presidenziale, deve disporre degli strumenti per farlo; privarla di autonomia significa lasciare il comando senza il suo correttivo cognitivo.
Nessun’altra democrazia collega l’intelligence alla sovranità esecutiva in questo modo. Altrove i servizi restano strutture governative; negli Stati Uniti, invece, la funzione informativa è incorporata nella fisiologia costituzionale del comando: il dispositivo attraverso cui la Presidenza percepisce il mondo e lo traduce in decisione.
Nel Regno Unito, MI5, MI6 e GCHQ si fondano su una cultura fiduciaria: l’equilibrio fra Corona, governo e Parlamento è informale e secolare. L’intelligence non è prerogativa costituzionale, ma continuità statale; la segretezza non sospende il diritto: ne è una forma. Per questo Londra non possiede un equivalente dell’Articolo Zero: la legittimità non si radica nella sopravvivenza della Repubblica, ma nella continuità della monarchia.
Nell’Europa continentale l’intelligence resta funzione amministrativa: forte controllo parlamentare, poteri esecutivi frammentati, assenza di un Commander in Chief sovranazionale. Le agenzie possono essere efficaci, ma non sono costituenti: non partecipano alla produzione della verità politica.
Israele occupa una posizione intermedia: non amministrazione né organo costituzionale, ma apparato esistenziale modellato da minacce permanenti. L’intelligence è una tecnologia collettiva di sopravvivenza, radicata nella società. Il fallimento del 7 ottobre 2023 ha mostrato il rovescio di un sistema ipercognitivo: la sicurezza può accecare.
Fuori dall’Occidente, il paradigma muta. In Cina, l’apparato non serve a conoscere il reale ma a impedire retroazioni sociali: è dispositivo disciplinare del Partito, non organo conoscitivo del sistema. La chiusura informativa genera accumulo di energia sociale non metabolizzata: entropia politica.
In Russia, dalla Čeka al KGB all’FSB, non esiste distinzione tra servizi e Stato: l’intelligence non descrive il reale, produce le categorie attraverso cui il potere interpreta se stesso. Questa fusione è forza e limite del sistema: l’auto-intossicazione informativa ha prodotto errori strutturali, dalla Crimea del 2014 all’Ucraina del 2022 fino alla marcia di Prigožin del 2023.
In Iran, l’intelligence è braccio della teologia politica: una competizione disciplinare tra Ministero e Pasdaran. Non persegue conoscenza, ma preservazione della dottrina. La verità non è politica: è religiosa.
Una sovranità in transito: l’evoluzione del legame fra Presidenza e intelligence
Ciò che distingue il modello americano è, dunque, l’intreccio strutturale — non funzionale, ma costitutivo — fra comando e conoscenza: l’intelligence non opera come un’amministrazione al servizio dell’esecutivo, bensì come la condizione stessa della sua possibilità di decidere. La Presidenza governa nella misura in cui l’intelligence vede. Se questa funzione cognitiva si deforma, non cambia un apparato, ma la geometria stessa della sovranità. Di qui deriva la forza, ma anche la vulnerabilità del sistema americano.
Per questo, il rapporto fra Presidenza e comunità d’intelligence oscilla da sempre fra dominio e dipendenza.
Nelle fasi di consolidamento (Roosevelt, Truman, Eisenhower) la Casa Bianca centralizza: la catena NSC–CIA costruisce un circuito diretto fra decisione e conoscenza. Nelle fasi di crisi (Kennedy dopo la Baia dei Porci, Nixon dopo il Watergate, Reagan con l’Iran-Contra) la Presidenza reagisce all’autonomia degli apparati tentando di riaffermare il primato del comando.Intanto, però, l’autonomia dell’intelligence cresce. Negli anni Sessanta e Settanta la CIA diventa un attore politico dotato di un proprio capitale cognitivo, non pienamente controllabile dalla politica. L’istituzione del President’s Daily Brief (PDB) sotto Kennedy e Johnson crea un canale privilegiato che, selezionando le informazioni, definisce anche il perimetro del pensabile: chi decide che cosa vedere decide che cosa è possibile fare.
Sul piano giuridico, la Corte Suprema consolida la prerogativa presidenziale. Da New York Times v. United States (1971) a Egan (1988) si afferma la constitutionalization of secrecy: il segreto non è una deroga, ma una componente strutturale della forma di governo.
’intelligence statunitense è così un sistema “presidenzializzato”, ma non interamente “presidenziale”: il Presidente ne è il vertice formale, ma l’apparato produce e media la conoscenza che orienta la decisione, curvando il campo del possibile. Il National Security Council, nato come organo di coordinamento, evolve rapidamente in motore operativo della politica estera e di sicurezza: è attraverso di esso che la Presidenza interiorizza l’intelligence. La conoscenza non è più esterna al potere: ne diventa la sostanza.
L’11 settembre 2001 apre una soglia epistemica nella sovranità americana. “Ground Zero” funziona da rivelatore: nel trauma collettivo affiora la struttura profonda dell’ordine costituzionale, che si richiude attorno alla priorità della sopravvivenza politica.
In quel punto di massima esposizione diventa visibile anche ciò che definiamo Articolo Zero: il principio implicito secondo cui la continuità della comunità politica sovrasta tutte le altre gerarchie costituzionali. L’Authorization for Use of Military Force (AUMF) del 2001, l’autorizzazione del Congresso all’uso della forza “necessaria e appropriata”, ne rappresenta l’immediata traduzione istituzionale: un mandato anticipato e potenzialmente illimitato, rivolto contro una minaccia dai confini soggettivi e temporali indefiniti. La delega preventiva diventa tecnica ordinaria di governo, più radicata nella previsione del rischio che nella sua constatazione.
Il Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) amplia in modo radicale strumenti di sorveglianza e detenzione preventiva: la sicurezza assume il profilo di una legalità dinamica, adattiva. Il Presidential Surveillance Program avviato nel 2002 — da cui deriveranno i programmi della National Security Agency (NSA) di raccolta massiva dei dati — istituzionalizza la conoscenza anticipata come logica di governo: la prova ex post è sostituita dalla pre-emption cognitiva, la previsione dal giudizio.
Con l’Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act (IRTPA, 2004) nasce il Director of National Intelligence (DNI), teoricamente coordinatore delle agenzie, in realtà snodo di una ricentralizzazione cognitiva sull’Esecutivo. La Corte Suprema, in decisioni come Hamdi v. Rumsfeld (2004) e Hamdan v. Rumsfeld (2006), tenta di fissare limiti, ma riconosce che la sicurezza nazionale è “funzione inerente” dell’esecutivo. La Costituzione non viene sospesa: si deforma, adattandosi a uno stato cognitivo di emergenza permanente in cui la verità assume la forma di un atto esecutivo.
Con Barack Obama, l’emergenza cessa di essere un evento e diventa forma di governo. Dopo otto anni di “Costituzione d’emergenza” sotto Bush, l’amministrazione democratica non ripristina un equilibrio precedente: integra il paradigma securitario nel linguaggio dell’etica e della trasparenza, ampliando al tempo stesso il potere cognitivo dell’Esecutivo.
Obama eredita un sistema in cui la verità è già funzione dell’Esecutivo e ne fa il fulcro della legittimazione morale. L’intelligence si trasforma in apparato riflessivo: l’Esecutivo si auto-osserva attraverso le proprie reti informative, presentando la conoscenza come responsabilità. La White House Situation Room, il National Counterterrorism Center e il DNI costituiscono i tre nodi di questa architettura cognitiva.
L’uso dei droni ne è il simbolo più chiaro: la decisione si traduce in algoritmo operativo; la legittimità è misurata in termini di precisione e proporzionalità, più che di giustificazione giuridica. L’etica diventa procedura. Come osserva Bruce Ackerman, la “modern emergency constitution” non è un’anomalia, ma lo specchio della democrazia americana nel XXI secolo.
Le riforme della NSA dopo le rivelazioni di Edward Snowden (2013) non smantellano l’apparato di sorveglianza: ne regolano l’uso. L’oversight diventa una grammatica amministrativa dell’eccezione, non il suo superamento. In questo quadro, la democrazia americana sviluppa una legalità adattiva: il diritto sopravvive traducendosi in etica della responsabilità e la trasparenza si trasforma in linguaggio di legittimazione del segreto.
Con Donald J. Trump la tensione fra verità e potere esplode in conflitto aperto. Nessun Presidente aveva mai delegittimato così frontalmente la comunità d’intelligence. Già nel discorso improvvisato al “Wall of Heroes” della CIA, al primo giorno di mandato, Trump profana il sacrario simbolico dei servizi, trasformandolo in palcoscenico personale: un gesto che segna la desacralizzazione dell’apparato cognitivo della Repubblica.
Per il Presidente, l’intelligence è una burocrazia cognitiva che ha espropriato la politica dalla gestione del reale. Non è più strumento, ma potere concorrente: un eso-scheletro che produce mappe del mondo senza attendere l’indirizzo della volontà sovrana. Da qui la retorica del deep state: il nemico interno non perché ostile, ma perché dotato di un potere autonomo di generare verità operative.
Il paradosso è che, nel tentativo di ridurre questa autonomia, Trump ne conferma la centralità. L’Executive Order 13859 (“Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence”, 2019) riconosce l’AI come “vital element of national security” e sposta la sicurezza nel dominio cognitivo: governare significa orientare l’informazione. La verità diventa un atto di comando; la conoscenza deve obbedire.
Lo scontro produce una frattura epistemica. Per la prima volta, la comunità d’intelligence reagisce in modo coordinato al Presidente, difendendo la propria competenza tecnica come fonte di legittimità politica: una sorta di reverse politicization, in cui l’apparato si politicizza contro la Casa Bianca per preservare la propria autonomia cognitiva. Come ha osservato l’ex analista CIA John Gentry, le reazioni negative verso Trump, da parte di ufficiali in servizio e in pensione, sono state “senza precedenti”.
Trump I segna così il passaggio dall’Articolo Zero come principio di sopravvivenza all’Articolo Zero come campo di conflitto epistemico: la posta in gioco non è più soltanto difendere la Repubblica, ma decidere chi ha il potere di stabilire che cosa sia vero.
Con Joe Biden la Casa Bianca tenta di ricomporre la frattura cognitiva creata da Trump. L’obiettivo non è ridurre il potere informativo dell’Esecutivo, ma riportarlo entro un linguaggio condiviso di responsabilità: l’etica come forma della legittimità. L’Executive Order 14110 (“Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence”, 2023) inaugura la fase normativa del potere cognitivo: l’AI diventa “ecosistema di sicurezza nazionale”, non più tecnologia ma ambiente integrato di governance.
Il NSC e l’OSTP si trasformano nei poli di una “governance cognitiva” multilivello che tenta di riallineare conoscenza, sicurezza e valori democratici. Ma questa moralizzazione genera un paradosso: l’etica non limita il potere, lo giustifica. Come nota la Harvard Law Review (2024), Biden ha reinserito l’enclave presidenziale della sicurezza nazionale in un quadro normativo, “ampliando la legittimità senza ridurre il potere”. La fiducia sostituisce la trasparenza; la cooperazione l’oversight.
Con la seconda amministrazione Trump, la dinamica fra Presidenza e apparato informativo entra in una nuova fase. Il segnale più chiaro arriva dalla CIA: John Ratcliffe, già Direttore dell’Intelligence Nazionale, è stato confermato dal Senato il 23 gennaio 2025 come nuovo direttore dell’Agenzia. La sua nomina viene interpretata come la volontà di riportare l’intelligence sotto una guida politicamente allineata alla Casa Bianca, e di riequilibrare l’Agenzia verso una postura più operativa che analitica — orientamento che la stampa specializzata segnala come già in corso nei primi giorni del nuovo mandato.
Parallelamente, diverse fonti interne e diplomatiche riferiscono che l’Esecutivo abbia avviato un processo più ampio di riorganizzazione della filiera cognitiva: revisione del ruolo del Director of National Intelligence, possibili sostituzioni ai vertici delle agenzie federali e un ridisegno delle strutture del National Security Council. Non tutti questi interventi risultano confermati in modo pubblico e dettagliato, ma gli alleati li percepiscono come un tentativo di concentrare la funzione informativa più vicino al centro politico della decisione, riducendo margini di autonomia e di contraddizione interna.
È sufficiente questo movimento — più intenzionale che dichiarato — per modificare il clima strategico attorno all’Esecutivo. Il principio implicito è chiaro: la lealtà precede la competenza. L’apparato non viene smantellato, ma riallineato: l’intelligence deve rientrare nel perimetro narrativo del Presidente, non limitarlo.
In questo quadro, la volontà politica entra in una zona tradizionalmente presidiata dalla funzione cognitiva del sistema. E qui si apre il punto critico: la sopravvivenza — l’“Articolo Zero” — attraversa una fase in cui rischia di diventare oggetto di auto-osservazione presidenziale, invece che cornice stabile dell’ordine costituzionale.
Parallelamente, il Trump AI Action Plan inaugura la dottrina della governance predittiva: l’AI non come strumento amministrativo, ma come infrastruttura di sovranità. Prevedere equivale a decidere. L’intelligence profonda non è più avversario esterno: viene assorbita nell’orbita presidenziale.
In questo scenario, decisione e previsione si fondono: governare significa progettare il reale. La democrazia americana entra nella fase quantica della sovranità, in cui l’Articolo Zero – la sopravvivenza come norma invisibile – diventa codice operativo dell’intero sistema.
Crisi, complessità ed entropia: l’ultimo test dell’Articolo Zero
Dalla Guerra fredda a Trump II la storia costituzionale americana può essere letta come una metamorfosi epistemica del potere. Con George W. Bush l’emergenza diventa il fondamento implicito dell’ordine; con Barack Obama si traduce in procedura amministrata; con il primo mandato di Donald Trump esplode come conflitto fra narrazione presidenziale e conoscenza istituzionale; con Joe Biden si ricompone come etica della responsabilità e della competenza; con Trump II si consolida come vero e proprio sistema operativo della sovranità.
L’intelligence, dentro questo lungo arco, cessa di essere funzione ancillare dell’Esecutivo e si configura come organo costituente della Repubblica: mente e memoria del sistema, il luogo in cui la sopravvivenza assume forma giuridica. Nell’America dell’Articolo Zero, la realtà giuridica diventa un sottoinsieme della realtà informativa: esiste ciò che l’apparato cognitivo riesce a osservare e classificare. La Costituzione non si spezza; si deforma, come lo spazio in un campo gravitazionale, adattandosi alla pressione degli eventi.
In un lessico mutuato dalla fisica quantistica, il potere presidenziale funziona come un osservatore: il suo atto di attenzione collassa la realtà operativa. La democrazia americana assume così la forma di un sistema di emergenza permanente, in cui l’Esecutivo è l’interfaccia cognitiva attraverso cui la conoscenza nazionale diventa decisione. In questo ambiente, l’intelligence non limita il potere: lo rende possibile. La verità non è più un giudizio ex post, ma un evento che orienta l’azione.
Il rischio maggiore nella fase Trump non risiede nell’uso politico dell’intelligence — dinamica fisiologica della storia americana, perché ogni Presidenza tende a piegare la conoscenza alle proprie priorità, ma entro un limite che il sistema, nel tempo, ricompone — bensì nella possibile rottura del circuito di auto-rinnovamento che ha sempre distinto la democrazia dagli Stati chiusi.
In un ambiente strategico dominato da complessità quantistica e minacce non-lineari, la sopravvivenza richiede meccanismi di retroazione: l’intelligence è uno di essi.
Quando però un Presidente mobilita l’Articolo Zero per tentare di inglobare la funzione cognitiva dell’intelligence dentro la propria narrazione, il circuito entra in una zona critica: i feedback negativi che normalmente correggono l’errore si attenuano, gli analisti tendono ad autocorreggersi verso il vertice, le fonti estere riducono la fiducia, l’opinione pubblica percepisce un deficit di visione istituzionale. Il sistema non metabolizza più complessità: la rigetta. L’errore, invece di produrre apprendimento, produce instabilità.
Il confronto con la Russia chiarisce il punto: apparati informativi chiusi, privi di feedback, generano entropia politica. È la logica dei sistemi opachi: l’instabilità affiora solo quando uno shock esterno spezza l’illusione di stabilità interna.
Gli Stati Uniti, storicamente, hanno funzionato come sistema aperto: il fallimento dell’11 settembre generò indagini, riforme, nuove istituzioni; la crisi produsse retroazione, e la retroazione innovazione. È questa capacità epistemica — trasformare il fallimento in conoscenza — che ha preservato per decenni la vitalità della democrazia americana.
La fase Trump rappresenta dunque un test sulla resilienza cognitiva del sistema. Se il potere presidenziale riuscisse a subordinare stabilmente la funzione conoscitiva alla propria narrazione, il circuito di retroazione si spezzerebbe, e con esso la differenza che ha sempre separato la democrazia americana dalle autocrazie: la capacità di riorganizzarsi attraverso il conflitto informativo, non contro di esso.
Tra crisi ed entropia la differenza è decisiva: la crisi trasforma, l’entropia paralizza.
In un mondo curvo e interdipendente sopravvive solo il sistema che resta aperto alla complessità. Gli Stati Uniti, finora, hanno scelto questa via. Resta da capire se sapranno farlo ancora.