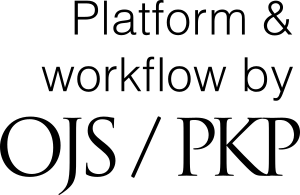Anticipazione DPCE Online 4-2022 - Verso la chiusura del laboratorio tunisino (mentre cresce il ruolo dell'opinione pubblica nella Umma)
di Ciro Sbailò
Il “laboratorio tunisino” è stato chiuso il 25 luglio del 2021. E ora il presidente Kaïs Saïed, professore di diritto costituzionale, cerca di buttare via la chiave.
La transizione tunisina fu caratterizzata dalla stipula di un patto costituzionale tra le principali anime politiche dell’area MENA: l’Islam popolare, le élite statuali post-coloniali che controllano l’apparato amministrativo, i partiti politici e i movimenti d’opinione di stampo liberal-democratico. Il patto – che ora dimostra tutta la sua fragilità – assegnava alle élite statuali il controllo della politica estera e di difesa, mentre l’Islam popolare e le altre realtà politiche se la sarebbero giocata dentro le dinamiche tra Esecutivo e Legislativo e nelle amministrazioni periferiche. A tal fine, la Costituzione del 2014 prevedeva una certa de-presidenzializzazione dell’Esecutivo, accompagnata da una riqualificazione del rapporto tra governo e Parlamento e da una conseguente valorizzazione del ruolo dei partiti.
Nel colpo di mano del luglio 2021, il Presidente ha esautorato il Primo Ministro, ha licenziato i ministri della Difesa e della Giustizia, e congelato il Parlamento. La Costituzione del 2014 in casi di gravi crisi prevedeva un ruolo centrale della Corte costituzionale, il cui funzionamento era però bloccato dai conflitti interni ai partiti. Saïed ha applicato quel che nel diritto costituzionale si chiama “fonte necessitata”: l’alternativa era la guerra civile. Poi ha nominato una donna premier (primo e finora unico caso nell’area), professore universitario ance lei. A quel punto, una Commissione di esperti ha messo mano al testo della nuova Costituzione, non senza dissensi interni, sui quali ha prevalso la volontà del Presidente, che ha insistito per una forte concentrazione nelle mani del Capo dello Stato.
Il referendum s’è tenuto il 25 luglio 2022, con un’affluenza del 27.5% (alle ultime elezioni politiche del 2019, l’affluenza è stata del 45% al primo turno, il 15 settembre, e del 57.8% al secondo turno, il 13 ottobre): il 92.3% degli elettori s’è espresso a favore.
Ora è il Presidente a stabilire l’indirizzo politico generale del Paese, mentre il capo del Governo è un suo “assistente” (Art. 87). Il Governo non risponde al Parlamento, ma allo stesso Presidente, che dispone anche di un vasto potere di iniziativa legislativa, mentre non vengono più previsti né l’impeachment né il conflitto di attribuzione tra Presidente e capo del Governo. La nuova Corte costituzionale è di esclusiva nomina presidenziale, il decentramento è scomparso e la libertà religiosa è garantita, purché, a giudizio dell’Esecutivo, non disturbi la quiete pubblica. L’Islam non è più religione di Stato, anche se il Presidente dovrà essere comunque musulmano (ma non potrà avere doppia cittadinanza e dovrà essere anche figlio e nipote di tunisini, onde evitare, come è stato fatto in altri Paesi islamici a forte emigrazione, la candidatura di leader cresciuti all’estero).
In vista delle prossime elezioni legislative, previste per il 17 dicembre, il presidente Saïed ha voluto una legge elettorale che mettesse una pietra tombale sul sistema dei partiti, che dal periodo coloniale francese caratterizza lo spazio pubblico tunisino nel contesto arabo-islamico. In base alla nuova legge (decreto 55 del 15 settembre 2022), il numero totale dei seggi nell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (la camera bassa del nuovo parlamento bicamerale) sarà di 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero di cui uno solo in Italia. Il Consiglio nazionale delle Regioni, la nuova camera alta, sarà composta invece da 72 seggi. Il meccanismo taglia fuori i partiti politici, privilegiando la rappresentanza diretta e rendendo difficili alleanze politiche, sia di governo sia di opposizione. Sono scesi assieme in piazza Ennahda ed il suo rivale laico Destour. Saïed ha perso persino l’appoggio della coalizione Somoud (un gruppo di esperti ed accademici che lo avevano sostenuto sin dal “colpo di mano” del 2021), secondo i quali il Presidente starebbe «imponendo decisioni unilaterali». Il Fronte di salvezza nazionale, la coalizione elettorale tunisina costituita da numerosi partiti politici in opposizione Ennahda quando questa era al governo, ha lanciato un appello al boicottaggio totale delle elezioni, pur mettendo però in guardia tutti i movimenti “pacifici e democratici” contro il ritorno ad un governo dell’Islam politico.
Il sistema dei partiti è stato il punto di forza dell’Islam popolare: pur muovendosi in un contesto partitico sostanzialmente laico, Ennahda è riuscita a diventare il centro del sistema, facendo pragmaticamente leva su radicamento sociale, tradizionale interclassismo e pluralismo culturale interno: si va dall’Islam in doppio petto che si muove con disinvoltura nel mondo finanziario globale al radicalismo anti-occidentale di alcune componenti giovanili, dai gruppi di volontari che sostituiscono lo Stato nelle aree emarginate agli intellettuali e opinionisti attivi sui media anche a livello internazionale, fino al mondo dell’Accademia e della ricerca scientifica. Per molti versi, Ennahda ricorda i grandi partiti politici italiani degli anni Settanta e Ottanta, come il PCI o la DC, come ebbero peraltro a constatare nel corso della XVII Legislatura i presidenti delle Commissioni Affari Esteri, rispettivamente, della Camera e del Senato, Fabrizio Cicchitto e Pier Ferdinando Casini. I due esponenti politici italiani parteciparono al Congresso di Ennahda, nel 2016, nel quale Ghannouchi annunciò la secolarizzazione del partito e la rinuncia all’Islam politico. Per chi conosce il mondo islamico, non fu affatto una sorpresa. L’ideologia dell’islamizzazione della società, contrapposta a quella della statualizzazione dell’Islam, si basa su un ridimensionamento dell’elemento statuale nello spazio pubblico, in una chiave universalistica e comunitaria. È significativo, a tale riguardo, il fatto che Ennahda, nella fase costituente tunisina, non abbia insistito sull’inserimento della Sharia nella Costituzione e, anzi, per certi aspetti, abbia paventato un tale inserimento, in quanto la combinazione tra la collocazione dei principi sciaraitici al vertice delle fonti, la presenza di un Corte costituzionale competente, per l’appunto, sul sistema delle fonti, insieme all’elezione diretta del Presidente, avrebbe portato a una replica del sistema egiziano, dove a partire dagli anni Ottanta, c’è stata una politica di drastico ridimensionamento, anche in chiave violentemente repressiva, della Fratellanza musulmana, accompagnata da una serie di riforme di stampo liberale promosse dall’alto, con il sostegno della Suprema Corte costituzionale, cui spetta in pratica l’interpretazione dei principi sciaraitici. La strategia costituzionale di Ennahada è stata prevalentemente improntata alla de-presidenzializzazione del sistema, al rafforzamento del rapporto tra governo e Parlamento, al decentramento territoriale, alla devoluzione e all’applicazione del principio di sussidiarietà. Sembrava, dunque, che fosse stata trovata la via islamica alla democrazia costituzionale.
Ma Ennahda, che ha ricoperto ruoli di leadership politica e istituzionale (Ghannouchi è stato sia ministro dell’Interno sia Speaker della Camera) non sembra essere stata all’altezza della situazione. La sua espansione nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni è stata accompagnata anche da un aggravamento di fenomeni endemici nella società tunisina, quali il clientelismo, il familismo e la corruzione politica, con conseguenti devastanti per il sistema-Paese. Le logiche spartitorie intrapartitiche si sono affermate in maniera parossistica, stressando il sistema ed esasperando la pubblica opinione: il citato blocco del funzionamento della Corte costituzionale è per l’appunto da ricondursi alle manovre di Ennahda sulla nomina dei giudici di spettanza del Parlamento. L’emergenza-covid ha trovato un sistema sanitario annichilito, il che ha fatto della Tunisia il Paese con il più alto numero di morti al mondo in rapporto alla popolazione. La disoccupazione è aumentata e la mobilità sociale – uno dei cavalli di battaglia dell’Islam popolare nel Nord Africa – praticamente azzerata, con giovani plurilaureati costretti a fare lavori di fortuna. La protesta è montata nel Paese, avendo come oggetto soprattutto Ennahda, che ha oscillato tra reazioni repressive e clamorosi mea culpa, raccogliendo risultati disastrosi alle elezioni politiche.
Ora Ennahda è sotto pressione anche per gravi vicende giudiziarie, che portano alla luce l’altra faccia del pragmatismo-comunitarismo islamico popolare: corruzione, nepotismo, rapporti opachi con potenze straniere e organizzazioni terroristiche.
Nella prima fase della stabilizzazione neo-autoritaria, il Presidente ha goduto del favore popolare, come confermano anche l’atteggiamento punitivo avuto dagli elettori nei confronti della Fratellanza (fenomeno analogo si registrò a suo tempo in Egitto e, con modalità peculiari, anche in Marocco e Algeria e persino nel disastrato teatro libico). Il Paese era devastato dalla crisi post-covid, nel corso della quale era emersa tutta l’inadeguatezza della classe dirigente tunisina post-Primavera. Si sperava che almeno Saïed avrebbe fermato il declino sociale ed economico del Paese.
L’invasione russa dell’Ucraina ha prodotto però gravi conseguenze in tutto il Nord Africa e soprattutto in Tunisia, molto esposta sul fronte dell’importazione di cerali (la prima fonte di approvvigionamento proteico della popolazione) e di energia. È venuta a mancare la farina per il pane: il 19 ottobre c’è stato uno sciopero nazionale dei panifici, con un tasso di partecipazione vicino al 100%. Oltre alla farina, nei supermercati mancano il latte, il burro, l’olio, lo zucchero, il caffè, il riso e altri alimenti di base. Nel nord del Paese, spesso non si trova carburante nelle stazioni di servizio. L’inflazione a settembre è arrivata 9,1%.
Il Presidente Saïed ha chiesto aiuti internazionali.
Il 15 ottobre 2022 il FMI ha siglato un accordo con la Tunisia per un programma di finanziamento di 1.9 miliardi di dollari della durata di 48 mesi finalizzato a sostenere le riforme nel Paese. L’UE ha sbloccato a marzo 2022 trecento milioni di euro, oltre ad aver lanciato un piano per l’ambiente del valore di 55 milioni di euro. Altri 150 milioni di euro sono stati erogati per sostenere il bilancio tunisino e si prevede un contributo fino a 20 milioni di euro per fronteggiare la crisi alimentare derivante dalla guerra in Ucraina. Questi aiuti comportano un prezzo da pagare: riforme liberali, detassazione, lotta al lavoro nero e all’evasione fiscale. Come già accaduto nel mondo arabo, tali riforme possono avere effetti devastanti se non realizzate in un contesto politico e amministrativo adeguato. Nell’Egitto di Sadat, ad esempio, la “open door policy” degli anni Settanta, con il conseguente abbandono della prospettiva socialista voluta a suo tempo da Nasser, fu vissuta dalla popolazione con grave disagio, visto che venivano meno le garanzie assistenziali e di sostegno che avevano caratterizzato la precedente fase politica. Ma c’è anche il rischio opposto, ovvero quello di una politica riformatrice fittizia, che finisce col premiare le classi dominanti. Sempre in Egitto, ma all’epoca di Mubarak, le privatizzazioni degli anni Novanta furono accompagnate da un aumento della corruzione e del clientelismo, con gravi contraccolpi economici e politici: ad esempio, molti giovani laureati o addottorati in materie economiche, anche all’estero, avevano visto un’occasione di crescita e diffusione della ricchezza; la delusione che seguì la mancata realizzazione di quella prospettiva fu un propellente per l’antioccidentalismo e per il radicalismo islamico.
La reputazione di Saïed e il destino della sua Costituzione dipenderanno in gran parte dalla capacità di gestire quei fondi. Nel frattempo, a favore del Presidente gioca l’assenza di una leadership alternativa, nella quale si riconoscano tutte le opposizioni. La situazione potrebbe sbloccarsi se Ennahda accettasse una leadership liberale per tutta l’opposizione, ritagliandosi un ruolo marginale sotto il profilo politico-istituzionale, ma decisivo su quello sociale. Ma il fallimento politico e le vicende giudiziarie del leader rendono la Fratellanza tunisina, almeno per ora, debole e inaffidabile agli occhi degli altri partiti.
Come accennato, la crisi della Fratellanza non è questione solo tunisina.
Il primo importante segnale in questo senso venne nel biennio egiziano 2012-2014, quando i Fratelli Musulmani si affermarono come forza politica dominante. Essi non furono tuttavia in grado di gestire il successo, trovandosi travolti sia dall’opinione pubblica sia dall’attivismo dei militari. Il declino della Fratellanza è segnato anche dai risultati disastrosi del fronte islamico-popolare alle elezioni marocchine del 2021. La Fratellanza musulmana s’è dimostrata molto deficitaria sotto il profilo della cultura di governo, nonché incapace di rielaborare la propria ideologia comunitarista e conservatrice. La sua “alternativa islamica”, da realizzarsi in concomitanza con il presunto declino delle democrazie occidentali, si presenta sempre di più come un processo velleitario e sostanzialmente destabilizzante, sia sul versante domestico, sia sul piano geopolitico.
Lo spazio sociale occupato finora dalla Fratellanza potrebbe, tuttavia, non restare vuoto. Va registrato l’emergere, forse anche per ragioni anagrafiche e generazionali, l’emergere, nell’Islam mediterraneo, di un’«opinione pubblica», soprattutto giovanile, che non si riconosce nell’aut-aut ideologico tra «alternativa islamica» e «asservimento all’Occidente» e che, al tempo stesso, presta attenzione agli aspetti sostanziali dell’ordinamento democratico (la stabilità, innanzitutto, che è la base di ogni possibile politica dei diritti: la deriva entropica innescata dai maldestri tentativi di conciliare pragmatismo politico e alternativa islamica rappresenta un pericolo concreto per ogni libertà). Molto si deve, forse, anche ai mass media e alla diffusione massiccia dell’uso dei social. Si pensi al ruolo dal movimento Hirak e altri movimenti nel processo costituente algerino, alle ondate di indignazione in Libano per la corruzione politica, alle timide ma non insignificanti riforme in Arabia Saudita in favore delle donne, a seguito di pressioni diffuse, esercitate ovviamente in maniera indiretta.
La vicenda tunisina gioca a sua volta un ruolo fondamentale in questo processo. Se Saïed saprà presentarsi quale garante della stabilità di un Paese chiave della Umma, allora avrà la forza e l’autorevolezza di gestire in maniera oculata gli aiuti esteri, senza sottostare a troppi ricatti di natura ideologica o sociale, e di avviare, dunque, la ricostruzione della Tunisia. Questo, poi, vorrà dire che la governance dei Paesi dell’area MENA non passa attraverso l’Islam popolare, ma, al contrario, attraverso il ridimensionamento di quest’ultimo. Viceversa, il fallimento del Presidente potrebbe innescare una nuova Primavera araba in tutta la Umma (in Egitto già si registrano tensioni in contemporanea con gli avvenimenti tunisini), dai connotati al momento non prevedibili.